In queste settimane la Fed ha deciso di riesaminare la propria strategia di politica monetaria, mettendo in discussione quel famoso “tasso naturale di disoccupazione” a cui solitamente le banche centrali guardano. A neanche un mese di distanza da questa decisione, nella giornata di mercoledì 30 settembre, si è pronunciata Christine Lagarde, Presidente della Bce, la quale - dopo aver constato la situazione di bassa inflazione - ha sottolineato la necessità di convergere verso altre priorità, auspicando, anche lei, una modifica degli obiettivi di politica monetaria.
Considerata la portata epocale di questi eventi, prima di analizzare le novità, riteniamo utile introdurre una breve permessa che ci consentirà di chiarire il contesto nel quale ci stiamo muovendo.
La matematizzazione dell’economia portata alle estreme conseguenze ha svuotato la disciplina della sua componente politica, legando il destino di milioni di persone allo sviluppo di una serie di indicatori che i governi considerano come standard di riferimento per le loro politiche di bilancio. Ma l’economia politica è una scienza sociale quindi esula dai principi di esattezza che tipicamente caratterizzano le scienze dure. Per questo motivo riteniamo superficiale distinguere tra teorie giuste e sbagliate e preferiamo parlare di teorie caratterizzate da sensibilità diverse che hanno fatto sì che i neoclassici considerassero con più attenzione i temi del capitale e i marxiani i temi del lavoro. All'interno di questo contesto, il ricorso alla matematica serve a modellizzare una realtà, in verità molto più complessa, la cui componente sociale non potrà mai essere efficacemente modellizzata.
Detto ciò, uno degli indicatori che influenza le nostre vite e sottolinea maggiormente la discrepanza emotiva tra le varie teorie è il tasso naturale di disoccupazione, poi diventato NAIRU (tasso di disoccupazione non inflazionistico). Questo tasso discende direttamente dalla teoria neoclassica, non a caso la sua applicazione ha significativamente rafforzato la posizione dei capitalisti (a cui i neoclassici guardano).
Per risalire alle origini di questo indicatore, bisogna fare un salto indietro nel tempo e andare direttamente al 1958 quando Alban William Phillips rilevò l’esistenza di una relazione inversa tra disoccupazione e salari nominali, econometricamente verificata per la Gran Bretagna del 1861-1957 e successivamente riformulata, da altri studiosi, con il tasso di variazione dei salari nominali, dando così origine alla famosa curva di Phillips.
Semplificando il discorso, se alla suddetta relazione originaria, si applica la formulazione dei prezzi delle imprese secondo l’approccio della nuova macroeconomia classica (una scuola di pensiero che si basa in gran parte sulla teoria neoclassica), in cui la variazione dei salari determina una variazione del livello generale dei prezzi, si sviluppa la cosiddetta curva di Phillips modificata che rileva una relazione inversa tra tasso di variazione dei prezzi e disoccupazione (figura in basso).
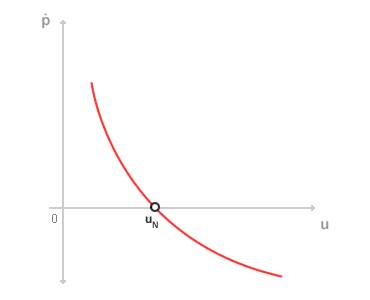
Sulla base dell’elaborazione originaria della curva di Phillips, data la stabilità dell’ambiente macroeconomico di quel periodo (anni ‘60), si iniziò a pensare che attraverso appropriate politiche monetarie un Paese potesse mantenere la disoccupazione verso i livelli desiderati (accettando un'inflazione più alta o più bassa , a seconda dell’obiettivo). Dalle successive rielaborazioni della curva si è sviluppato il concetto di tasso naturale di disoccupazione, un tasso oltre al quale, in base alle caratteristiche macroeconomiche del sistema di riferimento, la relazione inversa tra prezzi e disoccupazione cessa di esistere. Quindi, questo livello rappresenta un limite al di sotto del quale non si può andare.
Chiusa questa parentesi, ci preme sottolineare come questo tasso abbia influenzato in maniera significativa le nostre vite e ci abbia costretto a sacrificare sull’altare della presunta stabilità economica finanche la più piccola delle conquiste maturate nel tempo.
Oggi si tende a considerare come tasso naturale di disoccupazione quello non inflazionistico, cioè il tasso in corrispondenza del punto in cui la curva interseca l’asse delle ascisse (un della figura in alto), dove non si registra una variazione dell’inflazione. In corrispondenza di questo punto, secondo l’interpretazione dominante ci si trova in condizioni di pieno impiego in cui la produzione è al suo livello potenziale e il mercato del lavoro in equilibrio. Sulla base di queste considerazioni, la politica monetaria ha cominciato ad anteporre la componente tecnica a quella sociale, introducendo un target d’inflazione al 2%, (a cui, conseguentemente, si adegua il livello occupazionale).
Anche la politica fiscale è stata enormemente ridimensionata. Stando alla teoria, infatti, il tasso naturale di disoccupazione dipende da una serie di fattori istituzionali che regolano il mercato del lavoro, per esempio: si ritiene che elevati livelli di tutela dei lavoratori, sussidi di disoccupazione troppo “generosi”, minimo salariale, regole di contrattazione… possano scoraggiare l’acquisizione di manodopera da parte dei capitalisti provocando l’incremento del tasso sopracitato. Da qui si sono sviluppate le diverse riforme di flessibilizzazione del lavoro tese a rendere il mercato più appetibile.
Tuttavia, occorre precisare che il principio secondo il quale ad alti livelli di protezione dei lavoratori corrispondano alti livelli di disoccupazione si basa su una mera convenzione, smentita – tra l’altro – da numerose esperienze che dimostrano l’esatto contrario: la Danimarca storicamente vanta alti livelli di protezione, ma fino al 2008 ha registrato tassi di disoccupazione tra i più bassi in Europa; nel nostro Paese, invece, in cui sono state applicate le ricette di precarizzazione e flessibilizzazione del lavoro, le tutele sono diminuite, mentre il numero degli inoccupati è cresciuto nel tempo. Ne consegue che i lavoratori hanno perso la loro forza contrattuale a vantaggio dei capitalisti che, invece, hanno usufruito e continuano ad usufruire di manodopera a basso costo.
Proprio per questi motivi il tasso naturale di disoccupazione deve essere letto come il prodotto di una teoria – quella neoclassica- che attraverso le sue diverse articolazioni e spinta dalla diversa sensibilità di cui parlavamo all’inizio dell’articolo, ha permesso il consolidamento della struttura di classe capitalistica. Nell’elaborazione di questo indicatore infatti, vi è la consapevole incoscienza che impedisce alla teoria di guardare oltre le cifre, dietro cui si nascondono quelle vite umane dissolte, dalla teoria stessa, nella generalità astratta dell’agente economico.
Ciononostante, la decisione della Fed è stata chiara: come ha affermato il suo presidente, la Banca centrale americana non guarderà più al tasso naturale di disoccupazione perché “esso non coglie adeguatamente l’intera gamma di esperienze del mercato del lavoro” e, allo stesso tempo, non punterà più a ottenere un’inflazione del 2%, ma adotterà un average inflation targeting, ovvero un’inflazione pari in media al 2% nel tempo.
Insomma. il fuoco amico della Fed ha messo in guarda il sistema dalle possibili conseguenze e la Bce ha colto prontamente il messaggio ammettendo la necessaria affermazione di altre priorità rispetto all’ossessivo perseguimento dell’obiettivo inflazionistico. Queste dichiarazioni, non segnano tanto la sconfitta della teoria (internamente coerente) che ha portato alla determinazione del tasso naturale di disoccupazione quanto quella della sua componente socio-politica, che legittimando la disoccupazione ha accentuato il conflitto tra i lavoratori (costretti ad esercitare una concorrenza al ribasso sui salari per non rimanere inoccupati) e permesso ai capitalisti di imperare sulle macerie del contrasto sociale.
È in questo contesto che si inserisce l’altolà delle banche centrali, facendo emergere tutte le contraddizioni di un sistema chiaramente insostenibile.