L’economia politica come scienza nasce per interpretare il capitalismo. Un modo di produzione capace di rivoluzionare non solo l’organizzazione del lavoro, di dare un senso nuovo alla produttività, di concepire e realizzare città industriali, ma anche di determinare nuove contraddizioni sociali. È questo il punto di partenza del ragionamento che Antonio Calafati sviluppa nel suo ultimo libro, tessendo una trama, per certi versi inattesa ma estremamente coerente, fra le retoriche della scienza economica contemporanea, che egli svela grazie una lettura rigorosa dei Classici e in particolare di Adam Smith, e il sentiero di sviluppo intrapreso, e forse concluso, dalla Sinistra italiana.
Economista formatosi alla scuola di Giorgio Fuà ad Ancona, Calafati è autore di ricerche importanti nel campo dell’economia dello sviluppo locale e dell’analisi delle politiche pubbliche. Tra questi occorre ricordare almeno il libro “Economie in cerca di città, La questione urbana in Italia” (Donzelli, 2009) e il saggio “Aree interne: crescita e sviluppo economico” scritto insieme a Fabrizio Barca all’interno del documento ministeriale principale in cui venne definita la Strategia Nazionale per le Aree Interne nel 2014.
L’attenzione inconsueta che questo studioso ha dedicato nella sua vita intellettuale all’intreccio fra dinamica economica strutturale e dinamica istituzionale (in una prospettiva critica ma non riconducibile alle scuole sraffiane, postkeynesiane e men che meno marxiste) costituisce il presupposto de “L’uso dell’economia”. E può essere molto significativo per il lettore di questo pamphlet (un tascabile di 156 pagine scritto con lucidità e consapevolezza, persino con l’ambizione di vincere l’amarezza del presente) ritornare sulle opere passate di Calafati su richiamate. Infatti, il libro del 2009 e l’analisi delle aree interne da lui condotta nella squadra di studiosi impegnata presso il Ministero dello Sviluppo Economico rappresentano probabilmente i due momenti principali in cui questo scienziato sociale dalla forte vocazione politica ha cercato di mettersi al servizio delle istituzioni.
Fra Smith, Engels e Tocqueville
Non voglio presentare ai potenziali lettori di questo testo una sintesi delle tesi sostenute da Calafati. Voglio invece invitarli alla lettura e alla discussione de “L’uso dell’economia” perché lo ritengo uno dei libri più importanti scritti negli ultimi anni. Fra i motivi c’è la grande cura con cui l’autore recupera aspetti essenziali dell’opera smithiana. Concetti centrali di un libro che non si legge più, che sono messi nel cassetto dai ciarlatani sedicenti conoscitori de “La Ricchezza delle Nazioni” facenti insistentemente capolino sui nostri media: il significato di sussistenza economica, l’equilibrio sostanziale del mercato del lavoro e soprattutto la questione urbana.
“Le città che diventano metropoli – che si industrializzano e nelle quali si manifesta l’ascesa del capitalismo – sono luoghi senza natura.”
(p. 32)
È attraverso l’analisi dei luoghi dell’abitare umano e delle trasformazioni violente che li interessano (passando per Engels e Tocqueville grazie alla giusta considerazione delle indagini sul campo che il coautore del Manifesto del partito comunista e l’autore de La democrazia in America condussero a Manchester negli anni Quaranta dell’ Ottocento) che Calafati offre al lettore una prospettiva sempre più radicalmente politica per svelare le contraddizioni odierne della politica progressista:
“Nelle città si dovrebbe andare anche oggi, e sarebbe sufficiente osservare come la Sinistra italiana le narra e governa per capire in cosa sia consistita la sua metamorfosi.”
(p. 43)
Cambiamenti
Le metamorfosi della Sinistra italiana stanno tutte nel percorso che conduce dal capitalismo sociale al capitalismo sovrano. Nel linguaggio scelto da Calafati, il primo è un modello che “sembrava riscattare le democrazie europee dai loro tragici errori” (p. 50), regolamentando la terra, la moneta e il lavoro, riconosciuti come aspetti del vivere che non possono essere ridotti a merci, come notava Karl Polanyi.
Il capitalismo sovrano si afferma proprio quando il capitalismo sociale avrebbe potuto intraprendere un nuovo corso (si legga a tal proposito molto attentamente il capitolo 4 del libro di Calafati) e nasce da una falsa rappresentazione della realtà. Sta qui l’uso dell’economia, l’uso cioè al contempo di un sapere che si vorrebbe tutto scientifico (e che ingabbia ogni critica dell’economia politica) e dei rapporti materiali che si instaurano tra i gruppi sociali impegnati nella produzione e nello scambio che vengono piegati alle logiche di un mercato deregolato.
“Il paradigma mercatista che la Sinistra ha adottato è quello scientista, nel quale la disconnessione tra economia e società ha trovato la sua formalizzazione.
Non ammette dubbi sulla validità dei modelli di effetti utilizzati per valutare le politiche che propone”.
(p. 91)
Questo atteggiamento che ha giustificato l’adozione di politiche economiche molto approssimative ha contribuito a realizzare anche in Italia un’agonizzante ricerca della crescita economica senza considerare la rilevanza che la sussistenza economica, l’equilibrio sostanziale sul mercato del lavoro, la questione urbana, la regolamentazione della terra e della moneta hanno se si ha a cuore il governo dei dis-equilibri che un modo di produzione vocato a continue rivoluzioni industriali genera.
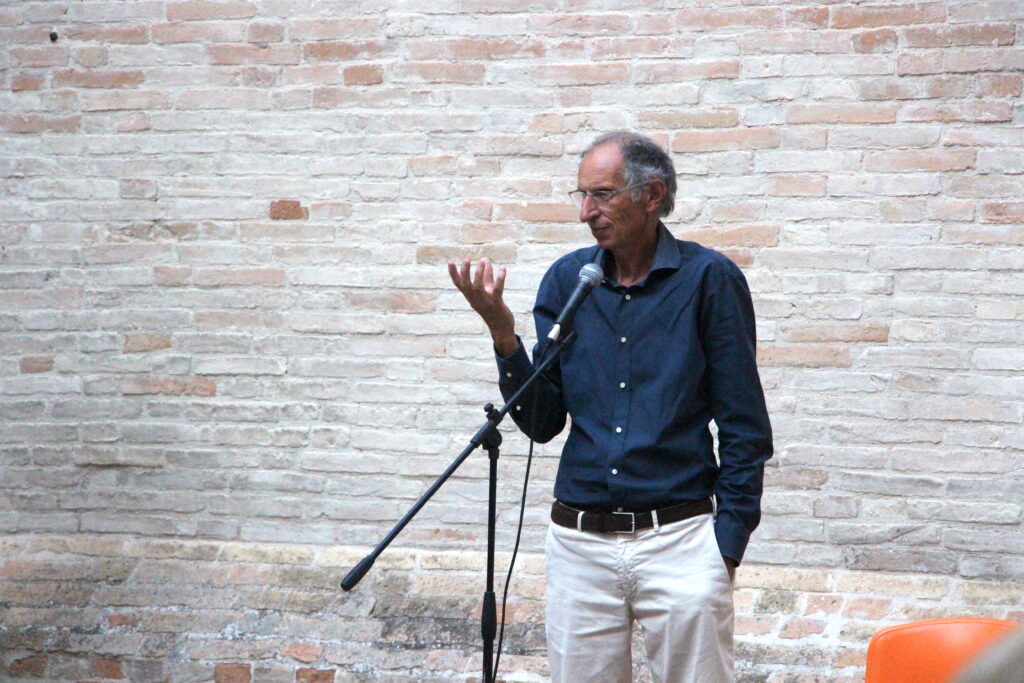
Dove nasce la Sinistra (e dove potrebbe rinascere)
L’immagine più forte che Calafati ci regala è affidata alle parole seguenti:
“La Sinistra è nata sulle strade di Manchester nel vortice della Rivoluzione industriale, quando lo sguardo etico incontra le sofferenze inflitte dall’organizzazione capitalistica del lavoro.
È nata rifiutando una prospettiva che declassa quelle sofferenze a (meritati) destini individuali, da affidare alla storia. E quando l’élite intellettuale della Sinistra smette di andare in cerca delle sofferenze altrui per consegnarle come priorità all’agenda politica, diventa inutile – e inutile lo è diventata”
(p. 130)
Lascio ai lettori il piacere – e il dovere – di ricercare in questo pamphlet le giustificazioni logiche e storiche che l’autore individua per supportare una tesi così severa, nella speranza che si diffonda almeno l’abitudine di chiamare le cose con il proprio nome: capitalismo è il nome del sistema economico in cui viviamo; la Sinistra italiana è invece una coppia di parole che non dà nome a nulla di vero – come scriveva già il 25 Aprile del 2003 nel suo ultimo articolo Luigi Pintor:
“La sinistra rappresentativa […] è fuori scena. Non sono una opposizione e una alternativa e neppure una alternanza, per usare questo gergo.
Hanno raggiunto un grado di subalternità e soggezione non solo alle politiche della destra ma al suo punto di vista e alla sua mentalità nel quadro internazionale e interno”.
Eppure, la fuoriuscita dalle retoriche dell’economia e il ripristino di un sapere economico per guardare la realtà contraddittoria che caratterizza il capitalismo è il presupposto per un uso altro dell’economia e per un mondo diverso possibile.


