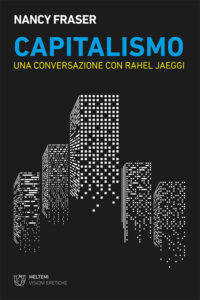“Capitalismo: una conversazione sulla teoria critica” (Meltemi Editore, 2019), di Nancy Fraser e Rahel Jaeggi, due delle più autorevoli studiose nel campo delle scienze sociali a livello mondiale, si riconosce come un testo rivoluzionario senza nemmeno il bisogno di cominciare a leggerlo. Già solo rigirandolo tra le mani, si individuano tre punti di discontinuità rispetto alla tradizionale letteratura sul tema economico-filosofico: sbatte il mostro in prima pagina, inserendone il nome nel titolo e dichiarandolo fin da subito oggetto della critica; quest’ultima prende la forma di un dialogo filosofico; il dialogo si svolge tra due donne.
Il primo punto, cioè l’interesse per il capitalismo in sé, appare attraversare un momento di revival negli attuali dibattiti politici e intellettuali, dopo un periodo di prolungata assenza. Tuttavia, questo ritorno in auge si muove in un contesto ambiguo: da una parte, la critica al capitalismo è inficiata da una forte confusione ideologica attorno al termine, spesso sbandierato per la sua forte valenza retorica più che come concetto effettivo; dall’altra, sempre più spesso gli intellettuali che lo prendono in esame lo fanno con spirito “da crocerossini”, tentando un suo salvataggio in extremis, nella credenza illusoria di potersi liberare della nostra ‘società dei rottweiler’1 adoperando blande museruole.
Fraser e Jaeggi si muovono su tutt’altro piano: la loro critica è radicale, in un duplice senso. Innanzitutto, rifiutano l’assetto economico vigente in toto senza possibilità di appello; in secondo luogo, non si limitano a contestarne i meccanismi distributivi, ma vanno a fondo in quelli produttivi, smontando davanti ai nostri occhi la “scatola nera” dell’economia e svelandone l’inerente ed essenziale tendenza alla crisi.
Questa decostruzione radicale trova nel dialogo un mezzo di espressione particolarmente efficace. È attraverso il botta e risposta delle due accademiche che si dipana il filo logico dell’analisi e la presenza di due punti di vista, affini ma non speculari, permette di anticipare e neutralizzare all’interno del sistema-libro possibili obiezioni o perplessità. Allo stesso tempo, il dialogo filosofico come strumento di ricerca offre un forte stimolo intellettuale reciproco verso l’instancabile messa in discussione dello status quo.
Tale metodo ha origini antiche: convenzionalmente, si tende ad associarlo alla figura di Socrate e alla sua “arte della maieutica”, nella quale il filosofo, a guisa di levatrice, aiutava l’interlocutore a “partorire” il proprio pensiero grazie alla presenza di un contraltare critico. È suggestivo pensale al dialogo (dal greco diàlogos, composto dalla particella διά, “attraverso”, e “λογος”, discorso) tra le due autrici come modo di passare attraverso il capitalismo e le sue istituzioni, sia nel senso di trascenderlo svelando le condizioni di necessità su cui si poggia, sia nel senso di superarlo, tratteggiando una bozza di socialismo “post-crescita” per il XXI secolo.
Terzo punto di particolare rilevanza: ci troviamo di fronte a un dibattito tutto al femminile. Si potrebbe obiettare che, negli ultimi decenni, la presenza femminile all’interno dell’accademia si è considerevolmente ampliata. Tuttavia, è ancora raro trovare un gruppo di sole donne che non parli esclusivamente di donne: siamo abituati a una prevalenza di quote rosa nei dibattiti attorno a temi legati alla sfera dell’identità di genere e nei quali, dunque, il sesso di chi scrive gioca un ruolo rilevante per la produzione in sé. Qui, invece, è del tutto secondario: Fraser e Jaeggi toccano sì la tematica della condizione femminile, ma lo fanno senza cedere alla tentazione di personalizzarla e inserendola in un sistema articolato di disuguaglianze, tutte facenti capo al sistema di produzione capitalista.
Il risultato di questo approccio di critica basato sul “sia/sia” – “sia classe e stato, sia redistribuzione e riconoscimento”2 – porta a una nuova definizione di capitalismo come “ordine sociale istituzionalizzato”. Formulazione che permette di andare oltre sia al rigido economicismo delle vecchie teorie marxiste, ancorato sul binomio struttura-sovrastruttura in un rapporto di semplicistica dipendenza, sia alla tendenza a concentrarsi esclusivamente sul piano del simbolico in reazione ai fenomeni odierni di “smaterializzazione” del lavoro, relegando l’economia a una sfera a sé stante.
Adottando un punto di vista dinamico su produzione e società, le due autrici riescono a inquadrare efficacemente l’importanza del lato economico della vita sociale. Condividono, in linea di massima, le caratteristiche costitutive del capitalismo delineate dall’ortodossia: divisione di classe tra lavoratori e padroni, mercificazione del lavoro, accumulazione di capitale, allocazione di surplus e risorse attraverso il mercato. Tuttavia,
le quattro caratteristiche principali che abbiamo identificato dipendono da altre cose, che costituiscono le loro sottostanti condizioni di possibilità. In assenza di queste altre cose, la logica economica capitalista che abbiamo descritto è inconcepibile. (…) In breve, il “primo piano economico” della società capitalista richiede uno “sfondo non economico”3.
In che cosa consistono, in concreto, le condizioni di possibilità tali per cui l’essenza del capitalismo – nella forma delle sue caratteristiche costitutive – si manifesti? Le due autrici ne individuano quattro: il lavoro non retribuito di riproduzione sociale; il capitale delle risorse naturali; il potere politico; l’oppressione razziale, che fornisce al sistema individui privi di tutela politica, non soltanto sfruttabili ma anche espropriabili. In tutti e quattro i fenomeni individuati, il capitale fallisce nel pagare i costi di riproduzione delle risorse che consuma, dando origine a fenomeni che Fraser definisce lotte di confine, distinte da quelle di classe ma altrettanto endemiche al sistema di produzione capitalista. Si tratta di quelle rivendicazioni sempre più pressanti che il neoliberismo progressista tenta di risolvere in separata sede, lasciando inalterata la struttura economica: emancipazione femminile e sessuale, emergenza climatica, crisi di rappresentanza, tensioni razziali.
Il capitalismo non può non essere in sé sessista, razzista, imperialista: le disuguaglianze che genera non sono suoi attributi accidentali, correggibili con un accorto riformismo, ma essenziali. E se tali ingiustizie permanessero anche in una società post-capitalista? Se fossero una “tendenza viziosa” insita in ogni forma di aggregazione sociale? In fin dei conti, anche prima della Rivoluzione Industriale, le minoranze non se la passavano troppo bene.
Nelle ultime pagine, le due filosofe si rendono conto della necessità di tratteggiare le basi per un futuro che si distacchi nettamente da tutto ciò che è stato. Una pars construens decisa e convincente quanto gli argomenti di critica sviluppati è ciò che manca: l’obiettivo astratto da perseguire è chiaro –in estrema sintesi, l’acquisizione di un “controllo democratico sul surplus sociale” – ma non lo sono altrettanto i concreti passaggi politici attraverso i quali perseguirlo. Il solito problema dei filosofi che interpretano il mondo e non lo cambiano. D’altra parte, il punto di forza di questo libro è l’accuratezza con cui spazza via i rottami ideologici del passato, preparando un terreno fertile di idee dalle quali ripartire.